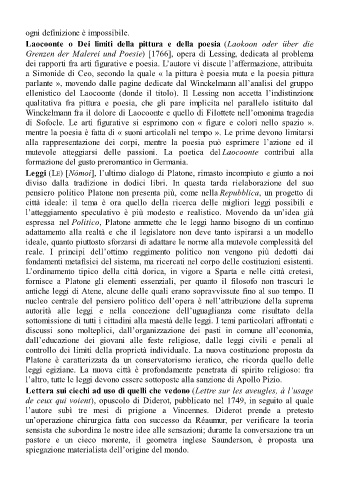Page 931 - Dizionario di Filosofia
P. 931
ogni definizione è impossibile.
Laocoonte o Dei limiti della pittura e della poesia (Laokoon oder über die
Grenzen der Malerei und Poesie) [1766], opera di Lessing, dedicata al problema
dei rapporti fra arti figurative e poesia. L’autore vi discute l’affermazione, attribuita
a Simonide di Ceo, secondo la quale « la pittura è poesia muta e la poesia pittura
parlante », movendo dalle pagine dedicate dal Winckelmann all’analisi del gruppo
ellenistico del Laocoonte (donde il titolo). Il Lessing non accetta l’indistinzione
qualitativa fra pittura e poesia, che gli pare implicita nel parallelo istituito dal
Winckelmann fra il dolore di Laocoonte e quello di Filottete nell’omonima tragedia
di Sofocle. Le arti figurative si esprimono con « figure e colori nello spazio ».
mentre la poesia è fatta di « suoni articolali nel tempo ». Le prime devono limitarsi
alla rappresentazione dei corpi, mentre la poesia può esprimere l’azione ed il
mutevole atteggiarsi delle passioni. La poetica del Laocoonte contribuì alla
formazione del gusto preromantico in Germania.
Leggi (LE) [Nómoi], l’ultimo dialogo di Platone, rimasto incompiuto e giunto a noi
diviso dalla tradizione in dodici libri. In questa tarda rielaborazione del suo
pensiero politico Platone non presenta più, come nella Repubblica, un progetto di
città ideale: il tema è ora quello della ricerca delle migliori leggi possibili e
l’atteggiamento speculativo è più modesto e realistico. Movendo da un’idea già
espressa nel Politico, Platone ammette che le leggi hanno bisogno di un continuo
adattamento alla realtà e che il legislatore non deve tanto ispirarsi a un modello
ideale, quanto piuttosto sforzarsi di adattare le norme alla mutevole complessità del
reale. I principi dell’ottimo reggimento politico non vengono più dedotti dai
fondamenti metafìsici del sistema, ma ricercati nel corpo delle costituzioni esistenti.
L’ordinamento tipico della città dorica, in vigore a Sparta e nelle città cretesi,
fornisce a Platone gli elementi essenziali, per quanto il filosofo non trascuri le
antiche leggi di Atene, alcune delle quali erano sopravvissute fino al suo tempo. Il
nucleo centrale del pensiero politico dell’opera è nell’attribuzione della suprema
autorità alle leggi e nella concezione dell’uguaglianza come risultato della
sottomissione di tutti i cittadini alla maestà delle leggi. I temi particolari affrontati e
discussi sono molteplici, dall’organizzazione dei pasti in comune all’economia,
dall’educazione dei giovani alle feste religiose, dalle leggi civili e penali al
controllo dei limiti della proprietà individuale. La nuova costituzione proposta da
Platone è caratterizzata da un conservatorismo ieratico, che ricorda quello delle
leggi egiziane. La nuova città è profondamente penetrata di spirito religioso: fra
l’altro, tutte le leggi devono essere sottoposte alla sanzione di Apollo Pizio.
Lettera sui ciechi ad uso di quelli che vedono (Lettre sur les aveugles, à l’usage
de ceux qui voient), opuscolo di Diderot, pubblicato nel 1749, in seguito al quale
l’autore subì tre mesi di prigione a Vincennes. Diderot prende a pretesto
un’operazione chirurgica fatta con successo da Réaumur, per verificare la teoria
sensista che subordina le nostre idee alle sensazioni; durante la conversazione tra un
pastore e un cieco morente, il geometra inglese Saunderson, è proposta una
spiegazione materialista dell’origine del mondo.