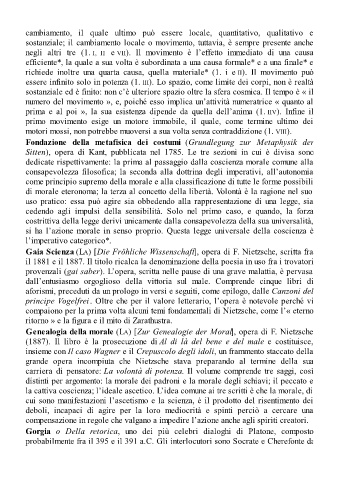Page 927 - Dizionario di Filosofia
P. 927
cambiamento, il quale ultimo può essere locale, quantitativo, qualitativo e
sostanziale; il cambiamento locale o movimento, tuttavia, è sempre presente anche
negli altri tre (1. I, II e VII). Il movimento è l’effetto immediato di una causa
efficiente*, la quale a sua volta è subordinata a una causa formale* e a una finale* e
richiede inoltre una quarta causa, quella materiale* (1. i e II). Il movimento può
essere infinito solo in potenza (1. III). Lo spazio, come limite dei corpi, non è realtà
sostanziale ed è finito: non c’è ulteriore spazio oltre la sfera cosmica. Il tempo è « il
numero del movimento », e, poiché esso implica un’attività numeratrice « quanto al
prima e al poi », la sua esistenza dipende da quella dell’anima (1. IIV). Infine il
primo movimento esige un motore immobile, il quale, come termine ultimo dei
motori mossi, non potrebbe muoversi a sua volta senza contraddizione (1. VIII).
Fondazione della metafisica dei costumi (Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten), opera di Kant, pubblicata nel 1785. Le tre sezioni in cui è divisa sono
dedicate rispettivamente: la prima al passaggio dalla coscienza morale comune alla
consapevolezza filosofica; la seconda alla dottrina degli imperativi, all’autonomia
come principio supremo della morale e alla classificazione di tutte le forme possibili
di morale eteronoma; la terza al concetto della libertà. Volontà è la ragione nel suo
uso pratico: essa può agire sia obbedendo alla rappresentazione di una legge, sia
cedendo agli impulsi della sensibilità. Solo nel primo caso, e quando, la forza
costrittiva della legge derivi unicamente dalla consapevolezza della sua universalità,
si ha l’azione morale in senso proprio. Questa legge universale della coscienza è
l’imperativo categorico*.
Gaia Scienza (LA) [Die Fröhliche Wissenschaft], opera di F. Nietzsche, scritta fra
il 1881 e il 1887. Il titolo ricalca la denominazione della poesia in uso fra i trovatori
provenzali (gai saber). L’opera, scritta nelle pause di una grave malattia, è pervasa
dall’entusiasmo orgoglioso della vittoria sul male. Comprende cinque libri di
aforismi, preceduti da un prologo in versi e seguiti, come epilogo, dalle Canzoni del
principe Vogelfrei. Oltre che per il valore letterario, l’opera è notevole perché vi
compaiono per la prima volta alcuni temi fondamentali di Nietzsche, come l’« eterno
ritorno » e la figura e il mito di Zarathustra.
Genealogia della morale (LA) [Zur Genealogie der Moral], opera di F. Nietzsche
(1887). Il libro è la prosecuzione di Al di là del bene e del male e costituisce,
insieme con Il caso Wagner e il Crepuscolo degli idoli, un frammento staccato della
grande opera incompiuta che Nietzsche stava preparando al termine della sua
carriera di pensatore: La volontà di potenza. Il volume comprende tre saggi, così
distinti per argomento: la morale dei padroni e la morale degli schiavi; il peccato e
la cattiva coscienza; l’ideale ascetico. L’idea comune ai tre scritti è che la morale, di
cui sono manifestazioni l’ascetismo e la scienza, è il prodotto del risentimento dei
deboli, incapaci di agire per la loro mediocrità e spinti perciò a cercare una
compensazione in regole che valgano a impedire l’azione anche agli spiriti creatori.
Gorgia o Della retorica, uno dei più celebri dialoghi di Platone, composto
probabilmente fra il 395 e il 391 a.C. Gli interlocutori sono Socrate e Cherefonte da