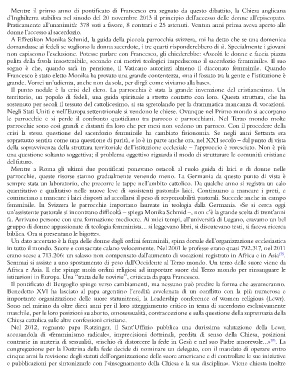Page 54 - Francesco tra i lupi
P. 54
Mentre il primo anno di pontificato di Francesco era segnato da questo dibattito, la Chiesa anglicana
d’Inghilterra stabiliva nel sinodo del 20 novembre 2013 il principio dell’accesso delle donne all’episcopato.
Praticamente all’unanimità: 378 voti a favore, 8 contrari e 25 astenuti. Ventun anni prima aveva aperto alle
donne l’accesso al sacerdozio.
A Effretikon Monika Schmid, la guida della piccola parrocchia svizzera, mi ha detto che se una domenica
domandasse ai fedeli se vogliono la donna sacerdote, i tre quarti risponderebbero di sì. Specialmente i giovani
non capiscono l’esclusione. Potesse parlare con Francesco, gli chiederebbe: «Ascolti le donne e faccia piazza
pulita della favola insostenibile, secondo cui motivi teologici impediscono il sacerdozio femminile». Il suo
sogno è che, quando sarà in pensione, il Vaticano autorizzi almeno il diaconato femminile. Quando
Francesco è stato eletto Monika ha provato una grande contentezza, «ma il fossato tra la gente e l’istituzione è
grande. Vorrei un’udienza, anche non da sola, per dirgli come viviamo alla base».
Il punto nodale è la crisi del clero. La parrocchia è stata la grande invenzione del cristianesimo. Un
territorio, un popolo di fedeli, una guida spirituale a stretto contatto con loro. Questa struttura, che ha
sostenuto per secoli il tessuto del cattolicesimo, si sta sgretolando per la drammatica mancanza di vocazioni.
Negli Stati Uniti e nell’Europa settentrionale si vendono le chiese. Ovunque nel Primo mondo si accorpano
le parrocchie e si perde il confronto quotidiano tra parroco e parrocchiani. Nel Terzo mondo molte
parrocchie sono così grandi e distanti fra loro che per mesi non vedono un parroco. Con il procedere della
crisi la stessa questione del sacerdozio femminile ha cambiato fisionomia. Se negli anni Settanta era
soprattutto sentita come una questione di parità, e lo è in parte anche ora, nel XXI secolo – dal punto di vista
della sopravvivenza della struttura territoriale dell’istituzione ecclesiale – l’approccio è rovesciato. Non è più
una questione soltanto soggettiva; il problema oggettivo riguarda il modo di strutturare le comunità cristiane
del futuro.
Mentre a Roma gli ultimi due pontificati ponevano ostacoli al ruolo guida di laici e di donne nelle
parrocchie, queste risorse stanno gradualmente venendo meno. La Germania da questo punto di vista è
sempre stata un laboratorio, che precorre le tappe nell’ambito cattolico. Da qualche anno si registra un calo
quantitativo e qualitativo nelle nuove leve di «assistenti pastorali» laici. Continuano a mancare i preti, e
cominciano a mancare i laici disposti ad accollarsi il peso di responsabilità pastorali. Succede anche in campo
femminile. In Svizzera le parrocchie importano laureate in teologia dalla Germania. «Se si cerca oggi
un’assistente pastorale si incontrano difficoltà – spiega Monika Schmid –, non c’è la grande scelta di trent’anni
fa. Arrivano persone con una formazione mediocre. Ai miei tempi, all’università di Lugano, eravamo un bel
gruppo di donne appassionate di teologia femminista... si leggevano libri, si discutevano testi, si faceva ricerca
biblica. Ora si presentano le bigotte».
Un dato accertato è la fuga delle donne dagli ordini femminili, spina dorsale dell’organizzazione ecclesiastica
in tutto il mondo. Suore e consacrate calano velocemente. Nel 2001 le professe erano quasi 792.317, nel 2011
175
erano scese a 713.206: un salasso non compensato dall’aumento di vocazioni registrato in Africa e in Asia .
Semmai si assiste a uno spostamento di peso dall’Occidente al Terzo mondo. Un terzo delle suore viene da
Africa e Asia. Il che spinge molti ordini religiosi ad importare suore dal Terzo mondo per rinsanguare le
istituzioni in Europa. Una “tratta delle novizie”, criticata da papa Francesco.
Il pontificato di Bergoglio spinge verso cambiamenti, ma nessuno può predire la forma che assumeranno.
Benedetto XVI ha lasciato al papa argentino l’eredità avvelenata di un conflitto con la più numerosa e
importante organizzazione delle suore statunitensi, la Leadership conference of women religious (Lcwr).
Sono nel mirino da oltre dieci anni per il loro atteggiamento critico in tema di sacerdozio esclusivamente
maschile, per le loro posizioni su aborto, omosessualità, contraccezione e sulla questione della supremazia della
Chiesa cattolica sulle altre confessioni cristiane.
Nel 2012, regnante papa Ratzinger, il Sant’Uffizio pubblica una durissima valutazione della Lcwr,
accusandola di «femminismo radicale», imprecisioni dottrinali, perdita di senso della Chiesa, posizioni
176
contrarie in materia di sessualità, «rischio di distorcere la fede in Gesù e nel suo Padre amorevole...» . La
congregazione per la Dottrina della fede decide di nominare un delegato, con il mandato di operare entro
cinque anni la revisione degli statuti dell’organizzazione delle suore americane e di controllare le sue iniziative
e pubblicazioni per sintonizzarle con l’«insegnamento della Chiesa e la sua disciplina». Viene chiesta inoltre