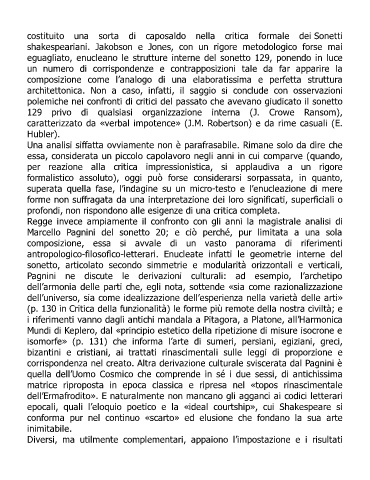Page 1777 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1777
costituito una sorta di caposaldo nella critica formale dei Sonetti
shakespeariani. Jakobson e Jones, con un rigore metodologico forse mai
eguagliato, enucleano le strutture interne del sonetto 129, ponendo in luce
un numero di corrispondenze e contrapposizioni tale da far apparire la
composizione come l’analogo di una elaboratissima e perfetta struttura
architettonica. Non a caso, infatti, il saggio si conclude con osservazioni
polemiche nei confronti di critici del passato che avevano giudicato il sonetto
129 privo di qualsiasi organizzazione interna (J. Crowe Ransom),
caratterizzato da «verbal impotence» (J.M. Robertson) e da rime casuali (E.
Hubler).
Una analisi siffatta ovviamente non è parafrasabile. Rimane solo da dire che
essa, considerata un piccolo capolavoro negli anni in cui comparve (quando,
per reazione alla critica impressionistica, si applaudiva a un rigore
formalistico assoluto), oggi può forse considerarsi sorpassata, in quanto,
superata quella fase, l’indagine su un micro-testo e l’enucleazione di mere
forme non suffragata da una interpretazione dei loro significati, superficiali o
profondi, non rispondono alle esigenze di una critica completa.
Regge invece ampiamente il confronto con gli anni la magistrale analisi di
Marcello Pagnini del sonetto 20; e ciò perché, pur limitata a una sola
composizione, essa si avvale di un vasto panorama di riferimenti
antropologico-filosofico-letterari. Enucleate infatti le geometrie interne del
sonetto, articolato secondo simmetrie e modularità orizzontali e verticali,
Pagnini ne discute le derivazioni culturali: ad esempio, l’archetipo
dell’armonia delle parti che, egli nota, sottende «sia come razionalizzazione
dell’universo, sia come idealizzazione dell’esperienza nella varietà delle arti»
(p. 130 in Critica della funzionalità) le forme più remote della nostra civiltà; e
i riferimenti vanno dagli antichi mandala a Pitagora, a Platone, all’Harmonica
Mundi di Keplero, dal «principio estetico della ripetizione di misure isocrone e
isomorfe» (p. 131) che informa l’arte di sumeri, persiani, egiziani, greci,
bizantini e cristiani, ai trattati rinascimentali sulle leggi di proporzione e
corrispondenza nel creato. Altra derivazione culturale sviscerata dal Pagnini è
quella dell’Uomo Cosmico che comprende in sé i due sessi, di antichissima
matrice riproposta in epoca classica e ripresa nel «topos rinascimentale
dell’Ermafrodito». E naturalmente non mancano gli agganci ai codici letterari
epocali, quali l’eloquio poetico e la «ideal courtship», cui Shakespeare si
conforma pur nel continuo «scarto» ed elusione che fondano la sua arte
inimitabile.
Diversi, ma utilmente complementari, appaiono l’impostazione e i risultati