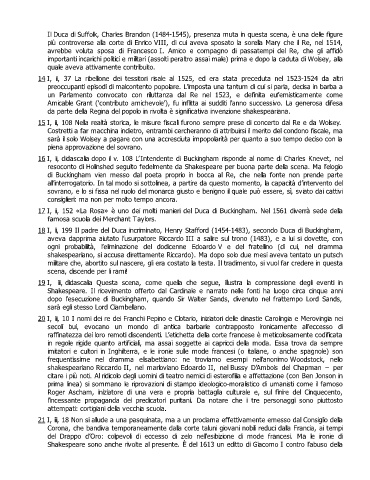Page 1754 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1754
Il Duca di Suffolk, Charles Brandon (1484-1545), presenza muta in questa scena, è una delle figure
più controverse alla corte di Enrico VIII, di cui aveva sposato la sorella Mary che il Re, nel 1514,
avrebbe voluta sposa di Francesco I. Amico e compagno di passatempi del Re, che gli affidò
importanti incarichi politici e militari (assolti peraltro assai male) prima e dopo la caduta di Wolsey, alla
quale aveva attivamente contribuito.
14 I, ii, 37 La ribellione dei tessitori risale al 1525, ed era stata preceduta nel 1523-1524 da altri
preoccupanti episodi di malcontento popolare. L’imposta una tantum di cui si parla, decisa in barba a
un Parlamento convocato con riluttanza dal Re nel 1523, e definita eufemisticamente come
Amicable Grant (‘contributo amichevole’), fu inflitta ai sudditi l’anno successivo. La generosa difesa
da parte della Regina del popolo in rivolta è significativa invenzione shakespeariana.
15 I, ii, 108 Nella realtà storica, le misure fiscali furono sempre prese di concerto dal Re e da Wolsey.
Costretti a far macchina indietro, entrambi cercheranno di attribuirsi il merito del condono fiscale, ma
sarà il solo Wolsey a pagare con una accresciuta impopolarità per quanto a suo tempo deciso con la
piena approvazione del sovrano.
16 I, ii, didascalia dopo il v. 108 L’Intendente di Buckingham risponde al nome di Charles Knevet, nel
resoconto di Holinshed seguito fedelmente da Shakespeare per buona parte della scena. Ma l’elogio
di Buckingham vien messo dal poeta proprio in bocca al Re, che nella fonte non prende parte
all’interrogatorio. In tal modo si sottolinea, a partire da questo momento, la capacità d’intervento del
sovrano, e lo si fissa nel ruolo del monarca giusto e benigno il quale può essere, sì, sviato dai cattivi
consiglieri: ma non per molto tempo ancora.
17 I, ii, 152 «La Rosa» è uno dei molti manieri del Duca di Buckingham. Nel 1561 diverrà sede della
famosa scuola dei Merchant Taylors.
18 I, ii, 199 Il padre del Duca incriminato, Henry Stafford (1454-1483), secondo Duca di Buckingham,
aveva dapprima aiutato l’usurpatore Riccardo III a salire sul trono (1483), e a lui si dovette, con
ogni probabilità, l’eliminazione del dodicenne Edoardo V e del fratellino (di cui, nel dramma
shakespeariano, si accusa direttamente Riccardo). Ma dopo solo due mesi aveva tentato un putsch
militare che, abortito sul nascere, gli era costato la testa. Il tradimento, si vuol far credere in questa
scena, discende per li rami!
19 I, iii, didascalia Questa scena, come quella che segue, illustra la compressione degli eventi in
Shakespeare. Il ricevimento offerto dal Cardinale e narrato nelle fonti ha luogo circa cinque anni
dopo l’esecuzione di Buckingham, quando Sir Walter Sands, divenuto nel frattempo Lord Sands,
sarà egli stesso Lord Ciambellano.
20 I, iii, 10 I nomi dei re dei Franchi Pepino e Clotario, iniziatori delle dinastie Carolingia e Merovingia nei
secoli bui, evocano un mondo di antica barbarie contrapposto ironicamente all’eccesso di
raffinatezza dei loro remoti discendenti. L’etichetta della corte francese è meticolosamente codificata
in regole rigide quanto artificiali, ma assai soggette ai capricci della moda. Essa trova da sempre
imitatori e cultori in Inghilterra, e le ironie sulle mode francesi (o italiane, o anche spagnole) son
frequentissime nel dramma elisabettiano: ne troviamo esempi nell’anonimo Woodstock, nello
shakespeariano Riccardo II, nel marloviano Edoardo II, nel Bussy D’Ambois del Chapman − per
citare i più noti. Al ridicolo degli uomini di teatro nemici di esterofilia e affettazione (con Ben Jonson in
prima linea) si sommano le riprovazioni di stampo ideologico-moralistico di umanisti come il famoso
Roger Ascham, iniziatore di una vera e propria battaglia culturale e, sul finire del Cinquecento,
l’incessante propaganda dei predicatori puritani. Da notare che i tre personaggi sono piuttosto
attempati: cortigiani della vecchia scuola.
21 I, iii, 18 Non si allude a una pasquinata, ma a un proclama effettivamente emesso dal Consiglio della
Corona, che bandiva temporaneamente dalla corte taluni giovani nobili reduci dalla Francia, ai tempi
del Drappo d’Oro: colpevoli di eccesso di zelo nell’esibizione di mode francesi. Ma le ironie di
Shakespeare sono anche rivolte al presente. È del 1613 un editto di Giacomo I contro l’abuso della