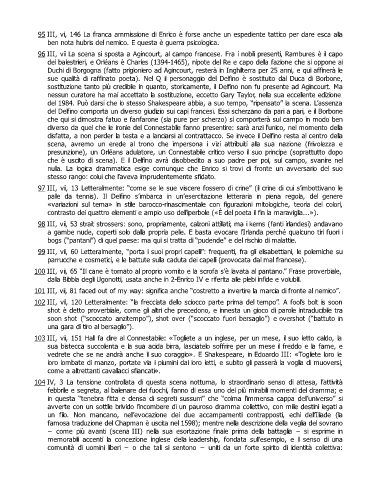Page 1746 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1746
95 III, vi, 146 La franca ammissione di Enrico è forse anche un espediente tattico per dare esca alla
ben nota hubris del nemico. E questa è guerra psicologica.
96 III, vii La scena si sposta a Agincourt, al campo francese. Fra i nobili presenti, Rambures è il capo
dei balestrieri, e Orléans è Charles (1394-1465), nipote del Re e capo della fazione che si oppone ai
Duchi di Borgogna (fatto prigioniero ad Agincourt, resterà in Inghilterra per 25 anni, e qui affinerà le
sue qualità di raffinato poeta). Nel Q il personaggio del Delfino è sostituito dal Duca di Borbone,
sostituzione tanto più credibile in quanto, storicamente, il Delfino non fu presente ad Agincourt. Ma
nessun curatore ha mai accettato la sostituzione, eccetto Gary Taylor, nella sua eccellente edizione
del 1984. Può darsi che lo stesso Shakespeare abbia, a suo tempo, “ripensato” la scena. L’assenza
del Delfino comporta un diverso giudizio sui capi francesi. Essi scherzano da pari a pari, e il Borbone
che qui si dimostra fatuo e fanfarone (sia pure per scherzo) si comporterà sul campo in modo ben
diverso da quel che le ironie del Connestabile fanno presentire: sarà anzi l’unico, nel momento della
disfatta, a non perder la testa e a lanciarsi al contrattacco. Se invece il Delfino resta al centro della
scena, avremo un erede al trono che impersona i vizi attribuiti alla sua nazione (frivolezza e
presunzione), un Orléans adulatore, un Connestabile critico verso il suo principe (soprattutto dopo
che è uscito di scena). E il Delfino avrà disobbedito a suo padre per poi, sul campo, svanire nel
nulla. La logica drammatica esige comunque che Enrico si trovi di fronte un avversario del suo
stesso rango: colui che l’aveva imprudentemente sfidato.
97 III, vii, 13 Letteralmente: “come se le sue viscere fossero di crine” (il crine di cui s’imbottivano le
palle da tennis). Il Delfino s’imbarca in un’esercitazione letteraria in piena regola, del genere
«variazioni sul tema» in stile barocco-rinascimentale con figurazioni mitologiche, teoria dei colori,
contrasto dei quattro elementi e ampio uso dell’iperbole («È del poeta il fin la maraviglia...»).
98 III, vii, 53 strait strossers: sono, propriamente, calzoni attillati; ma i kerns (fanti irlandesi) andavano
a gambe nude, coperti solo dalla propria pelle. E basta evocare l’Irlanda perché qualcuno tiri fuori i
bogs (“pantani”) di quel paese: ma qui si tratta di “pudende” e del rischio di malattie.
99 III, vii, 60 Letteralmente, “porta i suoi propri capelli”: frequenti, fra gli elisabettiani, le polemiche su
parrucche e cosmetici, e le battute sulla caduta dei capelli (provocata dal mal francese).
100 III, vii, 65 “Il cane è tornato al proprio vomito e la scrofa s’è lavata al pantano.” Frase proverbiale,
dalla Bibbia degli Ugonotti, usata anche in 2-Enrico IV e riferita alle plebi infide e volubili.
101 III, vii, 81 faced out of my way: significa anche “costretto a invertire la marcia di fronte al nemico”.
102 III, vii, 120 Letteralmente: “la frecciata dello sciocco parte prima del tempo”. A fool’s bolt is soon
shot è detto proverbiale, come gli altri che precedono, e innesta un gioco di parole intraducibile tra
soon shot (“scoccato anzitempo”), shot over (“scoccato fuori bersaglio”) e overshot (“battuto in
una gara di tiro al bersaglio”).
103 III, vii, 151 Hall fa dire al Connestabile: «Togliete a un inglese, per un mese, il suo letto caldo, la
sua bistecca succolenta e la sua acida birra, lasciatelo soffrire per un mese il freddo e la fame, e
vedrete che se ne andrà anche il suo coraggio». E Shakespeare, in Edoardo III: «Togliete loro le
loro lombate di manzo, portate via i piumini dai loro letti, e subito gli passerà la voglia di muoversi,
come a altrettanti cavallacci sfiancati».
104 IV, 3 La tensione controllata di questa scena notturna, lo straordinario senso di attesa, l’attività
febbrile e segreta, al balenare dei fuochi, fanno di essa uno dei più mirabili momenti del dramma; e
in questa “tenebra fitta e densa di segreti sussurri” che “colma l’immensa cappa dell’universo” si
avverte con un sottile brivido l’incombere di un pauroso dramma collettivo, con mille destini legati a
un filo. Non mancano, nell’evocazione dei due accampamenti contrapposti, echi dell’Iliade (la
famosa traduzione del Chapman è uscita nel 1598); mentre nella descrizione della veglia del sovrano
− come più avanti (scena III) nella sua esortazione finale prima della battaglia − si esprime in
memorabili accenti la concezione inglese della leadership, fondata sull’esempio, e il senso di una
comunità di uomini liberi − o che tali si sentono − uniti da un forte spirito di identità collettiva: