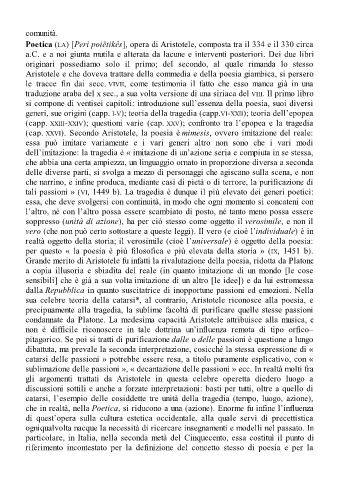Page 947 - Dizionario di Filosofia
P. 947
comunità.
Poetica (LA) [Perì poiētikês], opera di Aristotele, composta tra il 334 e il 330 circa
a.C. e a noi giunta mutila e alterata da lacune e interventi posteriori. Dei due libri
originari possediamo solo il primo; del secondo, al quale rimanda lo stesso
Aristotele e che doveva trattare della commedia e della poesia giambica, si persero
le tracce fin dai secc. VIVII, come testimonia il fatto che esso manca già in una
traduzione araba del x sec., a sua volta versione di una siriaca del VIII. Il primo libro
si compone di ventisei capitoli: introduzione sull’essenza della poesia, suoi diversi
generi, sue origini (capp. I-V); teoria della tragedia (capp.VI-XXII); teoria dell’epopea
(capp. XXIII-XXIV); questioni varie (cap. XXV); confronto tra l’epopea e la tragedia
(cap. XXVI). Secondo Aristotele, la poesia è mimesis, ovvero imitazione del reale:
essa può imitare variamente e i vari generi altro non sono che i vari modi
dell’imitazione: la tragedia è « imitazione di un’azione seria e compiuta in se stessa,
che abbia una certa ampiezza, un linguaggio ornato in proporzione diversa a seconda
delle diverse parti, si svolga a mezzo di personaggi che agiscano sulla scena, e non
che narrino, e infine produca, mediante casi di pietà o di terrore, la purificazione di
tali passioni » (VI, 1449 b). La tragedia è dunque il più elevato dei generi poetici:
essa, che deve svolgersi con continuità, in modo che ogni momento si concateni con
l’altro, né con l’altro possa essere scambiato di posto, né tanto meno possa essere
soppresso (unità di azione), ha per ciò stesso come oggetto il verosimile, e non il
vero (che non può certo sottostare a queste leggi). Il vero (e cioè l’individuale) è in
realtà oggetto della storia; il verosimile (cioè l’universale) è oggetto della poesia:
per questo « la poesia è più filosofica e più elevata della storia » (IX, 1451 b).
Grande merito di Aristotele fu infatti la rivalutazione della poesia, ridotta da Platone
a copia illusoria e sbiadita del reale (in quanto imitazione di un mondo [le cose
sensibili] che è già a sua volta imitazione di un altro [le idee]) e da lui estromessa
dalla Repubblica in quanto suscitatrice di inopportune passioni ed emozioni. Nella
sua celebre teoria della catarsi*, al contrario, Aristotele riconosce alla poesia, e
precipuamente alla tragedia, la sublime facoltà di purificare quelle stesse passioni
condannate da Platone. La medesima capacità Aristotele attribuisce alla musica, e
non è difficile riconoscere in tale dottrina un’influenza remota di tipo orfico–
pitagorico. Se poi si tratti di purificazione dalle o delle passioni è questione a lungo
dibattuta, ma prevale la seconda interpretazione, cosicché la stessa espressione di «
catarsi delle passioni » potrebbe essere resa, a titolo puramente esplicativo, con «
sublimazione delle passioni », « decantazione delle passioni » ecc. In realtà molti fra
gli argomenti trattati da Aristotele in questa celebre operetta diedero luogo a
discussioni sottili e anche a forzate interpretazioni: basti per tutti, oltre a quello di
catarsi, l’esempio delle cosiddette tre unità della tragedia (tempo, luogo, azione),
che in realtà, nella Poetica, si riducono a una (azione). Enorme fu infine l’influenza
di quest’opera sulla cultura estetica occidentale, alla quale servì di precettistica
ogniqualvolta nacque la necessità di ricercare insegnamenti e modelli nel passato. In
particolare, in Italia, nella seconda metà del Cinquecento, essa costituì il punto di
riferimento incontestato per la definizione del concetto stesso di poesia e per la