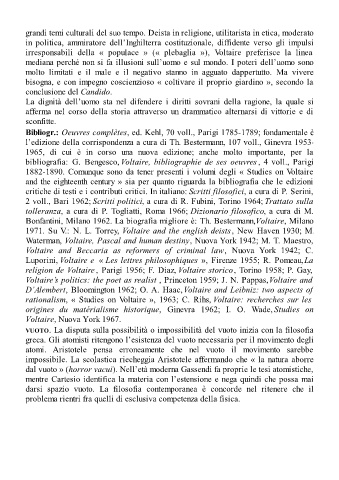Page 869 - Dizionario di Filosofia
P. 869
grandi temi culturali del suo tempo. Deista in religione, utilitarista in etica, moderato
in politica, ammiratore dell’Inghilterra costituzionale, diffidente verso gli impulsi
irresponsabili della « populace » (« plebaglia »), Voltaire preferisce la linea
mediana perché non si fa illusioni sull’uomo e sul mondo. I poteri dell’uomo sono
molto limitati e il male e il negativo stanno in agguato dappertutto. Ma vivere
bisogna, e con impegno coscienzioso « coltivare il proprio giardino », secondo la
conclusione del Candido.
La dignità dell’uomo sta nel difendere i diritti sovrani della ragione, la quale si
afferma nel corso della storia attraverso un drammatico alternarsi di vittorie e di
sconfitte.
Bibliogr.: Oeuvres complètes, ed. Kehl, 70 voll., Parigi 1785-1789; fondamentale è
l’edizione della corrispondenza a cura di Th. Bestermann, 107 voll., Ginevra 1953-
1965, di cui è in corso una nuova edizione; anche molto importante, per la
bibliografia: G. Bengesco, Voltaire, bibliographie de ses oeuvres , 4 voll., Parigi
1882-1890. Comunque sono da tener presenti i volumi degli « Studies on Voltaire
and the eighteenth century » sia per quanto riguarda la bibliografia che le edizioni
critiche di testi e i contributi critici. In italiano: Scritti filosofici, a cura di P. Serini,
2 voll., Bari 1962; Scritti politici, a cura di R. Fubini, Torino 1964; Trattato sulla
tolleranza, a cura di P. Togliatti, Roma 1966; Dizionario filosofico, a cura di M.
Bonfantini, Milano 1962. La biografia migliore è: Th. Bestermann, Voltaire, Milano
1971. Su V.: N. L. Torrey, Voltaire and the english deists, New Haven 1930; M.
Waterman, Voltaire, Pascal and human destiny, Nuova York 1942; M. T. Maestro,
Voltaire and Beccaria as reformers of criminal law, Nuova York 1942; C.
Luporini, Voltaire e « Les lettres philosophiques », Firenze 1955; R. Pomeau, La
religion de Voltaire , Parigi 1956; F. Diaz, Voltaire storico, Torino 1958; P. Gay,
Voltaire’s politics: the poet as realist , Princeton 1959; J. N. Pappas, Voltaire and
D’Alembert, Bloomington 1962; O. A. Haac, Voltaire and Leibniz: two aspects of
rationalism, « Studies on Voltaire », 1963; C. Rihs, Voltaire: recherches sur les
origines du matérialisme historique, Ginevra 1962; I. O. Wade, Studies on
Voltaire, Nuova York 1967.
VUOTO. La disputa sulla possibilità o impossibilità del vuoto inizia con la filosofia
greca. Gli atomisti ritengono l’esistenza del vuoto necessaria per il movimento degli
atomi. Aristotele pensa erroneamente che nel vuoto il movimento sarebbe
impossibile. La scolastica riecheggia Aristotele affermando che « la natura aborre
dal vuoto » (horror vacui). Nell’età moderna Gassendi fa proprie le tesi atomistiche,
mentre Cartesio identifica la materia con l’estensione e nega quindi che possa mai
darsi spazio vuoto. La filosofia contemporanea è concorde nel ritenere che il
problema rientri fra quelli di esclusiva competenza della fisica.