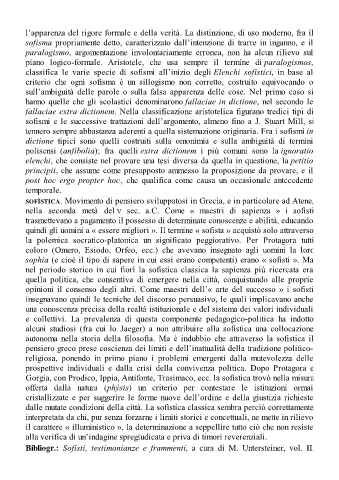Page 788 - Dizionario di Filosofia
P. 788
l’apparenza del rigore formale e della verità. La distinzione, di uso moderno, fra il
sofisma propriamente detto, caratterizzato dall’intenzione di trarre in inganno, e il
paralogismo, argomentazione involontariamente erronea, non ha alcun rilievo sul
piano logico-formale. Aristotele, che usa sempre il termine di paralogismos,
classifica le varie specie di sofismi all’inizio degli Elenchi sofìstici, in base al
criterio che ogni sofisma è un sillogismo non corretto, costruito equivocando o
sull’ambiguità delle parole o sulla falsa apparenza delle cose. Nel primo caso si
hanno quelle che gli scolastici denominarono fallaciae in dictione, nel secondo le
fallaciae extra dictionem. Nella classificazione aristotelica figurano tredici tipi di
sofismi e le successive trattazioni dell’argomento, almeno fino a J. Stuart Mill, si
tennero sempre abbastanza aderenti a quella sistemazione originaria. Fra i sofismi in
dictione tipici sono quelli costruiti sulla omonimia e sulla ambiguità di termini
polisensi (anfibolia); fra quelli extra dictionem i più comuni sono la ignoratio
elenchi, che consiste nel provare una tesi diversa da quella in questione, la petitio
principii, che assume come presupposto ammesso la proposizione da provare, e il
post hoc ergo propter hoc, che qualifica come causa un occasionale antecedente
temporale.
SOFÌSTICA. Movimento di pensiero sviluppatosi in Grecia, e in particolare ad Atene,
nella seconda metà del V sec. a.C. Come « maestri di sapienza » i sofisti
trasmettevano a pagamento il possesso di determinate conoscenze e abilità, educando
quindi gli uomini a « essere migliori ». Il termine « sofista » acquistò solo attraverso
la polemica socratico-platonica un significato peggiorativo. Per Protagora tutti
coloro (Omero, Esiodo, Orfeo, ecc.) che avevano insegnato agli uomini la loro
sophía (e cioè il tipo di sapere in cui essi erano competenti) erano « sofisti ». Ma
nel periodo storico in cui fiorì la sofistica classica la sapienza più ricercata era
quella politica, che consentiva di emergere nella città, conquistando alle proprie
opinioni il consenso degli altri. Come maestri dell’« arte del successo » i sofisti
insegnavano quindi le tecniche del discorso persuasivo, le quali implicavano anche
una conoscenza precisa della realtà istituzionale e del sistema dei valori individuali
e collettivi. La prevalenza di questa componente pedagogico-politica ha indotto
alcuni studiosi (fra cui lo Jaeger) a non attribuire alla sofistica una collocazione
autonoma nella storia della filosofìa. Ma è indubbio che attraverso la sofistica il
pensiero greco prese coscienza dei limiti e dell’inattualità della tradizione politico-
religiosa, ponendo in primo piano i problemi emergenti dalla mutevolezza delle
prospettive individuali e dalla crisi della convivenza politica. Dopo Protagora e
Gorgia, con Prodico, Ippia, Antifonte, Trasimaco, ecc. la sofistica trovò nella misura
offerta dalla natura (phýsis) un criterio per contestare le istituzioni ormai
cristallizzate e per suggerire le forme nuove dell’ordine e della giustizia richieste
dalle mutate condizioni della città. La sofìstica classica sembra perciò correttamente
interpretata da chi, pur senza forzarne i limiti storici e concettuali, ne mette in rilievo
il carattere « illuministico », la determinazione a seppellire tutto ciò che non resiste
alla verifica di un’indagine spregiudicata e priva di timori reverenziali.
Bibliogr.: Sofisti, testimonianze e frammenti, a cura di M. Untersteiner, vol. II,