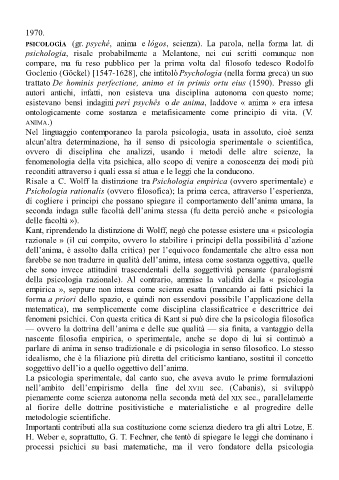Page 684 - Dizionario di Filosofia
P. 684
1970.
PSICOLOGÌA (gr. psyché, anima e lógos, scienza). La parola, nella forma lat. di
psichologia, risale probabilmente a Melantone, nei cui scritti comunque non
compare, ma fu reso pubblico per la prima volta dal filosofo tedesco Rodolfo
Goclenio (Göckel) [1547-1628], che intitolò Psychologia (nella forma greca) un suo
trattato De hominis perfectione, animo et in primis ortu eius (1590). Presso gli
autori antichi, infatti, non esisteva una disciplina autonoma con questo nome;
esistevano bensì indagini perì psychês o de anima, laddove « anima » era intesa
ontologicamente come sostanza e metafisicamente come principio di vita. (V.
ANIMA.)
Nel linguaggio contemporaneo la parola psicologia, usata in assoluto, cioè senza
alcun’altra determinazione, ha il senso di psicologia sperimentale o scientifica,
ovvero di disciplina che analizzi, usando i metodi delle altre scienze, la
fenomenologia della vita psichica, allo scopo di venire a conoscenza dei modi più
reconditi attraverso i quali essa si attua e le leggi che la conducono.
Risale a C. Wolff la distinzione tra Psichologia empirica (ovvero sperimentale) e
Psichologia rationalis (ovvero filosofica); la prima cerca, attraverso l’esperienza,
di cogliere i principi che possano spiegare il comportamento dell’anima umana, la
seconda indaga sulle facoltà dell’anima stessa (fu detta perciò anche « psicologia
delle facoltà »).
Kant, riprendendo la distinzione di Wolff, negò che potesse esistere una « psicologia
razionale » (il cui compito, ovvero lo stabilire i principi della possibilità d’azione
dell’anima, è assolto dalla critica) per l’equivoco fondamentale che altro essa non
farebbe se non tradurre in qualità dell’anima, intesa come sostanza oggettiva, quelle
che sono invece attitudini trascendentali della soggettività pensante (paralogismi
della psicologia razionale). Al contrario, ammise la validità della « psicologia
empirica », seppure non intesa come scienza esatta (mancando ai fatti psichici la
forma a priori dello spazio, e quindi non essendovi possibile l’applicazione della
matematica), ma semplicemente come disciplina classificatrice e descrittrice dei
fenomeni psichici. Con questa critica di Kant si può dire che la psicologia filosofica
— ovvero la dottrina dell’anima e delle sue qualità — sia finita, a vantaggio della
nascente filosofia empirica, o sperimentale, anche se dopo di lui si continuò a
parlare di anima in senso tradizionale e di psicologia in senso filosofico. Lo stesso
idealismo, che è la filiazione più diretta del criticismo kantiano, sostituì il concetto
soggettivo dell’io a quello oggettivo dell’anima.
La psicologia sperimentale, dal canto suo, che aveva avuto le prime formulazioni
nell’ambito dell’empirismo della fine del XVIII sec. (Cabanis), si sviluppò
pienamente come scienza autonoma nella seconda metà del XIX sec., parallelamente
al fiorire delle dottrine positivistiche e materialistiche e al progredire delle
metodologie scientifiche.
Importanti contributi alla sua costituzione come scienza diedero tra gli altri Lotze, E.
H. Weber e, soprattutto, G. T. Fechner, che tentò di spiegare le leggi che dominano i
processi psichici su basi matematiche, ma il vero fondatore della psicologia