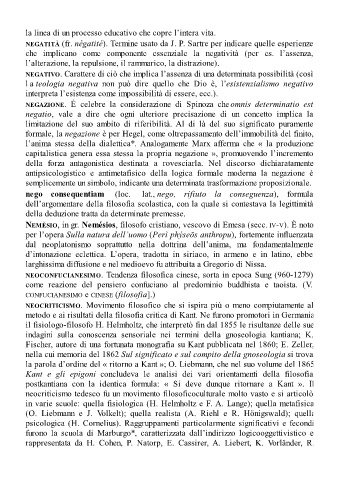Page 591 - Dizionario di Filosofia
P. 591
la linea di un processo educativo che copre l’intera vita.
NEGATITÀ (fr. négatité). Termine usato da J. P. Sartre per indicare quelle esperienze
che implicano come componente essenziale la negatività (per es. l’assenza,
l’alterazione, la repulsione, il rammarico, la distrazione).
NEGATIVO. Carattere di ciò che implica l’assenza di una determinata possibilità (così
l a teologia negativa non può dire quello che Dio è, l’esistenzialismo negativo
interpreta l’esistenza come impossibilità di essere, ecc.).
NEGAZIONE. È celebre la considerazione di Spinoza che omnis determinatio est
negatio, vale a dire che ogni ulteriore precisazione di un concetto implica la
limitazione del suo ambito di riferibilità. Al di là del suo significato puramente
formale, la negazione è per Hegel, come oltrepassamento dell’immobilità del finito,
l’anima stessa della dialettica*. Analogamente Marx afferma che « la produzione
capitalistica genera essa stessa la propria negazione », promuovendo l’incremento
della forza antagonistica destinata a rovesciarla. Nel discorso dichiaratamente
antipsicologistico e antimetafisico della logica formale moderna la negazione è
semplicemente un simbolo, indicante una determinata trasformazione proposizionale.
nego consequentiam (loc. lat., nego, rifiuto la conseguenza), formula
dell’argomentare della filosofia scolastica, con la quale si contestava la legittimità
della deduzione tratta da determinate premesse.
NEMÈSIO, in gr. Nemésios, filosofo cristiano, vescovo di Emesa (secc. IV-V). È noto
per l’opera Sulla natura dell’uomo (Perì phýseōs anthropu), fortemente influenzata
dal neoplatonismo soprattutto nella dottrina dell’anima, ma fondamentalmente
d’intonazione eclettica. L’opera, tradotta in siriaco, in armeno e in latino, ebbe
larghissima diffusione e nel medioevo fu attribuita a Gregorio di Nissa.
NEOCONFUCIANESIMO. Tendenza filosofica cinese, sorta in epoca Sung (960-1279)
come reazione del pensiero confuciano al predominio buddhista e taoista. (V.
CONFUCIANESIMO e CINESE (filosofia].)
NEOCRITICISMO. Movimento filosofico che si ispira più o meno compiutamente al
metodo e ai risultati della filosofia critica di Kant. Ne furono promotori in Germania
il fisiologo-filosofo H. Helmholtz, che interpretò fin dal 1855 le risultanze delle sue
indagini sulla conoscenza sensoriale nei termini della gnoseologia kantiana; K.
Fischer, autore di una fortunata monografía su Kant pubblicata nel 1860; E. Zeller,
nella cui memoria del 1862 Sul significato e sul compito della gnoseologia si trova
la parola d’ordine del « ritorno a Kant »; O. Liebmann, che nel suo volume del 1865
Kant e gli epigoni concludeva le analisi dei vari orientamenti della filosofia
postkantiana con la identica formula: « Si deve dunque ritornare a Kant ». Il
neocriticismo tedesco fu un movimento filosoficoculturale molto vasto e si articolò
in varie scuole: quella fisiologica (H. Helmholtz e F. A. Lange); quella metafisica
(O. Liebmann e J. Volkelt); quella realista (A. Riehl e R. Hönigswald); quella
psicologica (H. Cornelius). Raggruppamenti particolarmente significativi e fecondi
furono la scuola di Marburgo*, caratterizzata dall’indirizzo logicooggettivistico e
rappresentata da H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer, A. Liebert, K. Vorländer, R.